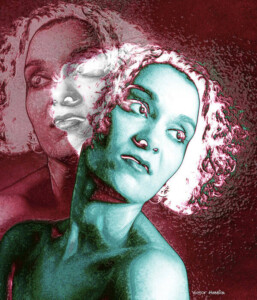 Articolo di Pier Pietro Brunelli – Psicologo-Psicoterapeuta
Articolo di Pier Pietro Brunelli – Psicologo-Psicoterapeuta  Disturbi di Personalità
Disturbi di Personalità
I disturbi di personalità sono condizioni cliniche caratterizzate da pattern di pensiero, emozione e comportamento rigidi, disadattivi e pervasivi.
-
Provocano sofferenza significativa e/o difficoltà nelle relazioni e nel funzionamento sociale/lavorativo. Quindi possono essere sia autoplastici (cioè disturbanti per se stessi) sia anche alloplastici (cioè disturbanti per gli altri). Va però aggiunto che vi sarebbero disturbi di personalità egosintonici, cioè non riconosciuti da chi ne è portatore, il quale semmai si considera persino dotato di certe qualità (che invece sono difettosità) e in diritto di dover essere accettato dagli altri, nonostante sia disturbante (il DNP Disturbo Narcisistico di Personalità è egosintonico). Vi sono poi Disturbi di Personalità egodistonici, per cui una persona soffre per il fatto di sentirsi condizionata da una personalità che sente di subire, senza poterla approvare. Vi sono poi casi misti, e questo dovrebbe farci comprendere che l’idea di Disturbo di Personalità quanto più venga valutata in modo rigido e uniformante tanto più è fallace (ma su questo ci soffermeremo più avanti).
Sono diagnosticati secondo i manuali DSM-5-TR e l’ICD-11. Il primo classifica i disturbi su 3 cluster (ma anche con criteri dimensionali che permettono di poterli intersecare tra loro); il secondo consente diagnosi meno rigidide, riguardanti i comportamenti e senza etichettare la persona con una nomenclatura psicodiagnostica, inoltre indica di valutare se il quadro sia lieve, moderato o grave. Nel DSM-5-TR i disturbi di personalità sono i seguenti:
– Cluster A (eccentrici o bizzarri)
- Disturbo paranoide → Sospettosità e diffidenza costante verso gli altri.
- Disturbo schizoide → Distacco dalle relazioni sociali e ridotta espressione emotiva.
- Disturbo schizotipico → Pensieri ed esperienze percettive eccentriche, sospettosità, difficoltà nelle relazioni sociali.
– Cluster B (drammatici, emotivi o impulsivi)
- Disturbo antisociale → Disprezzo per le regole e i diritti altrui, impulsività, mancanza di empatia.
- Disturbo borderline → Instabilità emotiva, relazionale e dell’identità, impulsività marcata.
- Disturbo istrionico → Ricerca costante di attenzione, emotività eccessiva, bisogno di essere al centro.
- Disturbo narcisistico → Grandiosità, necessità di ammirazione, mancanza di empatia.
– Cluster C (ansiosi o timorosi)
- Disturbo evitante → Timore del rifiuto, insicurezza sociale, evitamento di situazioni sociali.
- Disturbo dipendente → Bisogno eccessivo di essere accuditi, difficoltà a prendere decisioni autonome.
- Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità (OCPD) → Perfezionismo, rigidità mentale, ipercontrollo. (Da non confondere con il DOC, che è un disturbo d’ansia.)
➡ Esempio: una persona con disturbo borderline di personalità può avere relazioni instabili, impulsività e forte paura dell’abbandono, causando gravi problemi nella vita quotidiana. Tuttavia, se ci pensiamo, per quanto non si è esperti, risulta immediato che a molti può capitare di trovarsi in una condizione affettiva, relazionale e con se stessi come quella descritta.
D’altra parte un Disturbo di Personalità per quanto conclamato può manifestarsi anche sulla spinta di altri disturbi ib comorbilità, e quindi il DSM-5-Tr si fa carico di segnalarli. Anche questo intersecarsi di Disturbi di Personalità con altri disordini e disfunzioni dovrebbe mettere in guardia circa una effettiva possibilità di diagnosi primaria attinente la personalità. In buona sostanza fino a che punto è possibile dire che i problemi mentali e comportamentali di una persona siano dovuti essenzialmente a un Disturbo di Personalità ‘puro’? Su questo punto il dibattito tra gli studiosi è da molti anni accesso e in costante evoluzione, come vedremo nei seguenti paragrafi dove si valutano i tratti, gli stili e i disturbi funzionali, piuttosto che il disturbo di personalità come ‘blocco psicodiagnostico monografico’.
 2. Tratti di Personalità
2. Tratti di Personalità
I tratti di personalità sono pattern stabili di pensiero, emozione e comportamento che caratterizzano un individuo.
-
Sono dimensioni della personalità (ad es., estroversione, coscienziosità).
-
Non sono patologici di per sé, ma possono variare in intensità e manifestazione, fino a dare luogo a modi di pensare e agire inappropriati, dando luogo a disagio personale e /o interpersonale più o meno ‘pesante’
-
Un modello classico per descrivere i tratti di personalità comuni a tutte le persone, ma con modalità, dosaggi e interazioni differenziate, è il Big Five (Apertura, Coscienziosità, Estroversione, Amicalità, Nevroticismo).
➡ Esempio 1: una persona con un alto tratto di introversione può preferire ambienti tranquilli e interazioni limitate, senza che ciò implichi un problema psicologico. Ma quando si esagera nel chiudersi in se stessi, e i modi con cui lo si fa risultano incoerenti e persino invalidanti, allora si giunge ai tra normalità e psicopatologia, oppure ci si ritrova ‘francamente’ in un’area psicopatologica.
➡ Esempio 2: una persona con tratti narcisistici accentuati può avere difficoltà a gestire le critiche, ma senza manifestare il livello di compromissione tipico del DNP disturbo narcisistico di personalità. Questo spiegherebbe come persone che non sono diagnosticabili nel quadro di DNP possano essaere a volte ‘sintonizzate’ su modalità affettive, di pensiero e di azione di tipo narcisistico, risultando in tal modo alquanto disturbanti.
 2. Stili di Personalità
2. Stili di Personalità
Gli stili di personalità sono varianti normali della personalità che riflettono diverse modalità di adattamento.
-
Sono manifestazioni flessibili e funzionali dei tratti di personalità.
-
Ogni stile può avere aspetti positivi e limitazioni, ma non causa disagio clinico significativo.
-
Gli autori come Theodore Millon hanno descritto diversi stili (es. stile evitante, stile narcisistico). Anche in questo caso possiamo dire che quando uno stile diventa artefatto, rigido, inappropriato rispetto alle relazioni e alle situazioni, allora si entra in un’area che può recare sofferenza psicologica a se stessi e a volte anche agli altri, e questo anche se vogliamo considerarla a prescindere da una dimensione psicopatologica. Diciamo che lo stile inappropriato di certe persone, laddove comporta un non curarsi del malessere che può generare in altri, andrebbe comunque considerato disturbante.
➡ Esempio: uno stile perfezionista può portare a ottimi risultati lavorativi, ma se eccessivo potrebbe diventare disfunzionale.
 4. Disturbi Funzionali di Personalità
4. Disturbi Funzionali di Personalità
I disturbi funzionali di personalità si collocano in una zona intermedia tra gli stili di personalità e i disturbi di personalità. Si tratta tuttavia di definizioni che cercano di risolvere dubbi e carenze dal momento che si parla di quadri complessivi di personalità, e quindi valutando che è più corretto parlare di funzioni cognitivo-comportamentali che possono dare luogo ad alterazioni, ambivalenze, ambiguità e quindi condizionamenti disturbanti per se stessi ed altri.
Non rientrano nei criteri di un disturbo di personalità pienamente sviluppato, ma possono causare difficoltà in certe situazioni o momenti di stress, senza determinare un malfunzionamento globale. Quindi mentre quando si parla di tratti e di stili non si vogliono indicare fattori disturbanti di per se stessi, bensì normali in tutti gli individui, ma che tuttavia possono diventare disturbanti in determinate condizioni, quando si parla di disturbi funzionali o di disturbi di personalità si considerano modi di essere, di fare e di pensare che sono di per se stessi valutati come psicopatologici.
 LA PSICODIAGNOSI SITUAZIONISTA CRITICA IL CONCETTO DI “DISTURBO DI PERSONALITA’
LA PSICODIAGNOSI SITUAZIONISTA CRITICA IL CONCETTO DI “DISTURBO DI PERSONALITA’ La psicodiagnosi situazionista è una prospettiva critica nei confronti della psicodiagnosi tradizionale, in particolare rispetto ai disturbi di personalità. Si basa su un’idea centrale: la personalità non è una struttura rigida e stabile nel tempo, ma varia in base al contesto e alle situazioni. In particolare viene messo in crisi il concetto di COSTANZA, ovvero risulta quasi impossibile dimostrare scientificamente che una persona sia costantemente in un certo modo. Le persone cambiano nel corso della vita e alcune, pur manifestando per lunghi periodi il cosiddetto ‘brutto carattere’ possono ristrutturarsi come se avessero intrapreso una sorta di ‘conversione’. Una persona conosciuta per essere di indole cattiva, potrebbe diventare buona, o viceversa (semplificando al massimo…). Perciò il situazionismo in psicologia sostiene che il comportamento umano è fortemente influenzato dalle variabili ambientali e non solo da eventuali tratti stabili dell’individuo.
Quindi il concetto di “disturbo di personalità”, definito dai manuali diagnostici (DSM-5-TR e ICD-11), è stato spesso criticato da diverse prospettive, in particolare da quella situazionista. Alcune delle principali critiche si possono così riassumere:
-
La diagnosi di un disturbo di personalità presuppone che i tratti disfunzionali siano stabili e pervasivi, mentre la ricerca dimostra che la personalità è più flessibile e situazionale di quanto si pensasse. Occorre considerare il modo in cui i comportamenti problematici emergono in specifiche interazioni sociali o ambientali.
-
I disturbi di personalità hanno spesso criteri sovrapposti tra loro, il che porta a una scarsa affidabilità diagnostica. Ad esempio, molte persone soddisfano i criteri per più di un disturbo contemporaneamente.
-
Etichettare un individuo con un disturbo di personalità può portare a uno stigma e a una visione deterministica, tralasciando il ruolo delle esperienze di vita e del contesto sociale
In sintesi: l’approccio situazionista suggerisce che, invece di concentrarsi su etichette diagnostiche fisse, sarebbe più utile comprendere le modalità in cui gli individui si adattano (o meno) ai diversi contesti. Questo può favorire interventi più mirati e meno stigmatizzanti, focalizzati sul cambiamento delle dinamiche relazionali e ambientali piuttosto che su una presunta patologia intrinseca della persona.
 LA PSICODIAGNOSI INTERAZIONISTA CONSIDERA I DISTURBI DI PERSONALITA’ COME RELAZIONALI
LA PSICODIAGNOSI INTERAZIONISTA CONSIDERA I DISTURBI DI PERSONALITA’ COME RELAZIONALI
La psicodiagnosi interazionista è un approccio che si concentra sulle modalità attraverso cui la personalità di un individuo si manifesta e si struttura nel contesto delle relazioni interpersonali. In tal senso l’approccio interazionista risulta alternativo e critico rispetto alla diagnosi puramente categoriale e intrapsichica tipica dei manuali diagnostici come il DSM-5-TR o l’ICD-11. L’interazionismo è alterantivo anche al situazionismo, dal momento che considera la personalità di un individuo sia modo in cui si relaziona con se stesso (livello intrapersonale) sia per come si relaziona con gli altri (livello interpersonale). La personalità non è una monade che si impone agli altri e all’ambiente, ma è un flusso dinamico di interazioni che avvengono nel modo di ‘trattare se stessi’, gli altri e i contesti nei quali si deve confrontare, dando luogo circuiti di azion-reazione che vanno a caratterizzarne le forme e i comportamenti. Le variabili interne e le variabili esterne interagiscono così che si parla di personalità come effetto di una co-varianza che, per quanto possa apparire entro quadri di relativa stabilità, è sempre sottilmente mutevole e a volte questa mutevolezza può perfino risultare sorprendente, sia in senso positivo che negativo, o nel susseguirsi di ‘altalene’ di ‘crescita’ e ‘decrescita’ personale.
La personalità dunque non è un modo di essere innato e statico, ma frutto di un continuo adattamento o disadattamento in rapporto agli altri, all’ambiente e anche rispetto ai suoi processi cognitivi e psicobiologici ‘interni’. Perciò le dinamiche patologiche non sono viste solo come “caratteristiche del soggetto”, ma come modalità ripetitive e disfunzionali di interazione con l’ambiente e con gli altri, mediate da processi consapevoli e inconsapevoli interiori. La valutazione psicodiagnostica ha quindi il compito di osservare e analizzare i pattern relazionali e comunicativi della persona, nonché il modo di valutare, gestire o di subire se stessa, sempre relativamente alle variabili interpersonali e ambientali esterne da cui viene influenzata e che a sua voltra va a influenzare.
Nell’ottica interazionista, i disturbi di personalità non sono entità fisse e intrinseche, ma pattern relazionali e ripetitvi che generano sofferenza o disfunzione. Si tratta di circoli viziosi che si rinforzano per la messa in atto di schemi difensivi e aggressivi per i quali non si riescono ad individuare alternative. Si tratta strategie di adattamento disfunzionali (spesso apprese in età precoce) che possono diventare sempre più problematiche e rigide nel tempo.
Esempio 1: Il disturbo borderline viene visto non solo come instabilità interna, ma come una modalità relazionale che alterna idealizzazione e svalutazione dell’altro, generando rotture frequenti nei legami.
Esempio 2: Il disturbo narcisistico è letto come un pattern che si fonda su una relazione sbilanciata tra bisogni di conferma e incapacità di tollerare la frustrazione relazionale.
In conclusione ricordiamoci di non fossilizzarsi mai sulle etichette di DISTURBO DI PERSONALITA’ di qualsiasi tipo. A livello scientifico il dibattito che le mette in discussione è vastissimo. Ormai raramente vengono usate come diagnosi primaria dai professionisti della salute mentale. Se ne fa uso solo per indicare un quadro di riferimento, ma ai fini di una psicodiagnosi volta ad un progetto di intervento e cura sono considerate relative e secondarie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
In un prossimo articolo che presenteremo con un link a questo che avete letto (se siete arrivati fin qui) parleremo del concetto di PERSONALITA’SECONDO JUNG E HILLMAN, ai quali faccio prevalentemente riferimento nella mia attività di ricerca e di clinico.
Segui il mio canale Youtube e non dimenticare di iscriverti per darmi una mano a far crescere la mia attività divulgativa per il ‘bne psicologico’ di tutti – troverai video relativi agli articoli e altri suargomenti che possono interessarti per una conoscenza e un’armonizzazione degli aspetti psicologici della vita individuale e collettiva https://www.youtube.com/@PierPietroBrunelli
Cerca
Articoli recenti
Commenti recenti
- Pier Pietro Brunelli su Bugiardi, ipocriti e manipolatori affettivi, saperne di più per potersi difendere
- Pier Pietro Brunelli su Bugiardi, ipocriti e manipolatori affettivi, saperne di più per potersi difendere
- oskar su Bugiardi, ipocriti e manipolatori affettivi, saperne di più per potersi difendere
- Pier Pietro Brunelli su Riflessioni sul padre
- Pier Pietro Brunelli su Riflessioni sul padre
 Pier Pietro Brunelli – Psicologo-Psicoterapeuta
Pier Pietro Brunelli – Psicologo-Psicoterapeuta 